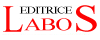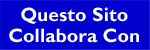Sono trascorsi 75 anni dal 9 maggio 1950, una data spartiacque che ha assunto un valore simbolico tanto da essere scelta come la Festa dell’Europa. Quel giorno Robert Schuman, allora ministro degli esteri francese, rese nota una dichiarazione che sarebbe diventata la pietra miliare della costruzione europea sulla base della quale l’anno successivo nacque la prima Comunità europea, quella del carbone e dell’acciaio (Ceca). Da questa, procedendo per gradi e con ripetuti allargamenti (dai 6 Paesi fondatori fino agli attuali 27, dopo la diaspora britannica) e ampliamenti delle competenze delle istituzioni comunitarie, si è arrivati all’attuale Unione europea.
La ’dichiarazione Schuman’ nelle intenzioni voleva segnare la fine dell’epoca delle guerre intestine per inaugurare invece una nuova e promettente fase di pace e cooperazione economica, che a sua volta avrebbe generato una più stretta collaborazione e solidarietà politica. Non si può negare che molte delle promesse generate dai Trattati di Roma sottoscritti nel 1957 siano state rispettate e oggi l’Ue è senza dubbio una delle aree più sviluppate al mondo, terra di democrazia e in generale di diritti, con standard medi di vita molto più elevati rispetto al resto del mondo. Allo stesso tempo va però rilevato come tante possibili prospettive siano rimaste a metà del guado sul piano dell’economia, della tutela dei diritti e della lotta alla povertà, della sicurezza, oltre che del peso politico sullo scenario planetario. A questo va aggiunto che purtroppo la guerra è tornata in Europa, benché l’Ue non ne abbia alcuna responsabilità, e anzi si è spesa per sostenere in vari modi il Paese aggredito - l’Ucraina - dall’aggressore russo.
In questo senso, al giro di boa dei 75 anni la ’dichiarazione Schuman’ mantiene un forte significato quale radice del cammino dei Ventisette, eppure è innegabile come l’Ue che ne è scaturita abbia bisogno, come avvenne nel dopoguerra, di lasciarsi alle spalle un passato ingombrante per cercare nuove vie per il futuro. Giungono infatti al pettine i nodi dell’era della globalizzazione: crisi demografica e migratoria, economia finanziarizzata, neocolonialismi, crisi ambientale e via elencando, mentre si affacciano ulteriori sfide da affrontare come la sicurezza, la rivoluzione digitale, gli squilibri interni tra Paesi e regioni, l’instabilità geopolitica oltre i confini europei. Sembrano anche venir meno alcune amicizie consolidate (Stati Uniti, Turchia) e si fanno avanti agguerriti competitori (Cina, India, Brasile, Corea del Sud e vari stati del sud del mondo). Ma non è tanto di una nuova dichiarazione che l’Europa ha bisogno, quanto di vera coesione, di capacità decisionale e leadership politica, di rafforzare la sua democrazia e l’efficienza istituzionale con cessioni di sovranità dagli stati all’Ue in settori strategici in cui la sovranità nazionale ormai appare insufficiente.
Occorre inoltre completare il mercato unico, concertare una politica estera e di difesa comune, nonché definire livelli irrinunciabili di sicurezza sociale per tutti i 450 milioni di cittadini dell’unione. È inoltre necessario valorizzare tutti quegli aspetti che possano contribuire a ridare un’anima all’Europa, per usare un attento richiamo del già compianto papa Francesco, e a far sentire apparentati gli europei con l’affermazione del concetto di cittadinanza europea. Quest’opera può passare dalla storia e dalle memorie collettive, da cultura, arte, studio reciproco delle lingue, viaggi, come consentito dal meritorio programma Erasmus dell’Ue, grazie al quale le giovani generazioni possono crescere sentendosi appunto europee.
Con lungimiranza la ’dichiarazione Schuman’ prevedeva che l’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme, e sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. Un passo dopo l’altro, tra successi, spinte in avanti e repentini dietrofront, per poi tornare ad avanzare verso l’unità: una formula delineata nel ’50 e valida ancora oggi e in futuro.
Guido Monti